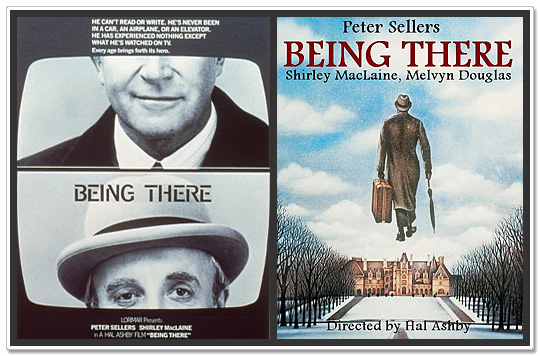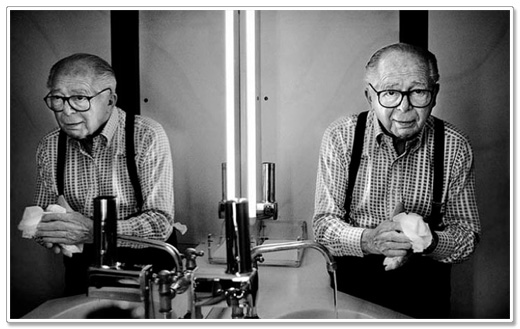Marilyn!
Il 5 agosto di 50 anni fa moriva Marilyn Monroe, la più grande icona femminile del ventesimo secolo. Attorno alla sua scomparsa si sono versati fiumi di inchiostro con le ipotesi e le congetture più fantasiose. «Chissà perchè», disse l’attrice in un’intervista un anno prima della morte, «i giornalisti, i biografi, scrivono di me come di un’orfana: forse avvolgere di un mistero più fitto e più grande la mia vita serve alle case di produzione, ai registi, ai manager, ai giornali e a tutti coloro che attorno a me crescono, si arricchiscono, si moltiplicano…», dimostrando di conoscere alla perfezione i meccanismi che media e produttori avevano adottato nei suoi confronti. Il mistero più grande – quello che riguarda la sua fine, avvenuta a soli 36 anni – sarebbe arrivato da lì a pochi mesi e sarebbe stato in larga parte creato ad arte per costruire intorno a Norma Jeane Baker [questo il suo vero nome] la leggenda che ammanta tutto quel che è, e tuttora rappresenta Marilyn Monroe.
Qualcuno una volta disse che Marilyn ha incarnato le due più forti emozioni umane: la speranza e la paura. E forse il successo eterno della Diva si gioca proprio intorno a spinte contrastanti. Come mai nessun’altra prima di lei, infatti, rappresentò nell’immaginario popolare l’idea di una donna adulta, consapevole della propria sessualità vissuta in modo assolutamente genuino, che però coesisteva insieme alle fragilità tipiche dell’infanzia e dell’adolescenza. Tale condizione si rifletteva anche nel suo lavoro: come attrice – difatti – fu sempre combattuta fra l’insicurezza ed un notevolissimo, istintivo talento. Una cosa è certa: la complessa, introspettiva, delicata e tormentata personalità di Norma Jeane, quella per cui fu costretta a frequentare psichiatri e case di cura, era quanto di più distante dalla mondanità e dal glamour della Diva. Indubbiamente la vera Marilyn fu proprio quella del bisogno d’amore disatteso, delle amare confessioni e delle poesie strazianti: «Mi aprono… e non trovano assolutamente nulla… è uscita soltanto segatura così sottile – come da una bambola di pezza – e la segatura si sparge sul pavimento e il tavolo».